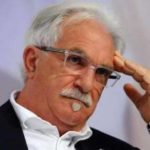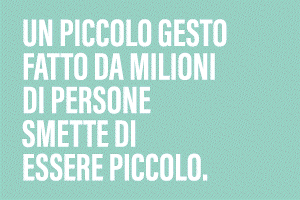di Raffaele Bonanni
ROMA (ITALPRESS) – L’Italia vive un paradosso che non è più congiunturale: le imprese cercano lavoratori e spesso non li trovano, ma le buste paga perdono valore reale. In un’economia dinamica, la scarsità di manodopera dovrebbe far salire i salari e riequilibrare la distribuzione del reddito. Da noi accade l’opposto: domanda di lavoro in crescita, retribuzioni inchiodate, inflazione che erode il potere d’acquisto. Ne deriva una fragilità che colpisce famiglie, imprese e Paese, frenando consumi e fiducia.
Per questo il tema non può restare appeso a misure episodiche: servirebbe al più presto una strategia unica, condivisa da parti sociali, governo e politica, capace di trasformare il lavoro in leva di sviluppo e non in fattore di impoverimento.
Il biennio 2022-23 ha accelerato l’impoverimento salariale. L’impennata dei prezzi energetici ha alzato i costi di produzione, mentre i rinnovi contrattuali sono arrivati in ritardo: resta un gap di circa otto punti rispetto all’inflazione dell’ultimo quadriennio. Gli sgravi fiscali e contributivi varati prima dal governo Draghi e poi da quello Meloni hanno compensato solo in parte, alleggerendo il cuneo per i redditi più bassi ma costando, secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, oltre 25 miliardi di risorse pubbliche. Tamponare gli effetti, però, non basta se le cause restano intatte.
Il nodo è più antico. Da trent’anni i salari italiani arrancano per produttività debole, prevalenza di imprese piccole e sottocapitalizzate, eccesso di occupazione a bassa qualificazione, diffusione di contratti instabili e part-time involontari, oltre al lavoro sommerso. Le crisi del 2008 e del 2020 hanno aggravato un declino già in corso, nonostante bonus, sussidi e riforme degli ammortizzatori sociali. È un sentiero che ha reso cronica la distanza tra crescita economica e crescita dei redditi.
Questo impianto stratificato non ha ridotto le disuguaglianze né fermato la povertà lavorativa. Anche la contrattazione nazionale registra divari crescenti: i settori meno innovativi faticano a rinnovare i contratti e a sostenere aumenti che altrove sono fisiologici, segno di un modello che premia poco investimenti, innovazione e competenze. Così il lavoro qualificato resta sottoutilizzato e quello povero si moltiplica.
Dentro questo quadro la Legge di bilancio introduce una tassazione agevolata per gli aumenti dei prossimi rinnovi: scelta positiva e inedita, ma limitata ai redditi sotto i 28 mila euro e dunque fonte di nuove disarmonie rispetto ai contratti già chiusi. È la prova di una fiscalità usata come surrogato della contrattazione, con il rischio di distorcerne logiche e gerarchie professionali, oltre che di spostare ogni confronto sul terreno dell’emergenza.
Senza una riforma che rafforzi la contrattazione decentrata — l’unica capace di legare salari a produttività, investimenti e qualità del lavoro — lo Stato sarà invocato sempre per tamponare, anziché risolvere. Le parti sociali più responsabili raccolgano la sfida, innovando gli strumenti negoziali e puntando sulla partecipazione dei lavoratori ai risultati: altrimenti il paradosso di oggi diventerà la normalità di domani, con costi pesanti per coesione sociale, cultura partecipativa e dignità del lavoro.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).